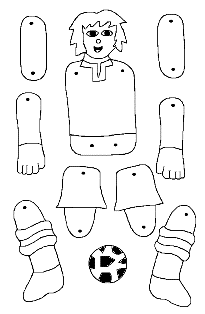
Non creda il Lettore che voglia io risolvere l’enigma, ma ogni tanto è possibile pure rilevare un segno, una traccia di discrezione, di intima resa a se stessa, da parte di una delle cose meno discrete di questo mondo. Allora, così, vale pure la pena di interrogarsi laddove essa concede ingresso a sporadici visitatori. In fondo la gloria è uno degli ingredienti del calcio. È indispensabile per i piatti di alta ristorazione, nella fattispecie. Ma non è detto che essa si riservi soltanto per i palati fini. Restando per un altro momento nella metafora culinaria, è un ingrediente che si può trovare pure nella cucina casereccia. Anche un gol segnato in un campo di periferia, durante una partita tra due squadre fuori categoria, dopo uno di quei tornei rionali più sentiti di un mondiale, fa parlare di sé a lungo. Capita che il suo autore passi di bocca in bocca per anni, se quel gol ha sortito effetti memorabili. Ma in quel caso, l’eco gloriosa prima o poi si dimette dal tempo e si rifugia tra i ricordi di pochi reduci di quella stessa partita, consegnata a tre o quattro amatori sconosciuti, piuttosto che a volumi di almanacchi.
Poco male. È un caso di esercizio di popolarità, un impiego momentaneo del successo, che scarabocchia un’ipotesi di unzione e poi lascia il foglio incompleto, oppure strappa tutto, finendo anch’essa nei nulla di fatto. Non sarebbe nemmeno giusto pensare che si sia vanificata, perché la vanagloria delude le attese e si esaurisce prima che arrivi il responso della disputa. La vanagloria non partecipa, si iscrive alla gara e poi dà forfait. Ben altra storia è la consegna gloriosa che resta per sempre nei verbali della storia. Quella è una permanenza, a volte dolce, altre volte ingombrante.
A questo proposito, visto il suo rapporto confidenziale coi media e con gli artisti, la popolarità – sia ben chiaro che non voglio mutuarla col concetto di gloria – conserva anche elementi che non dipendono solo dalla legittimazione universale. Proprio per il suo antico compromesso con i poteri di diffusione, ha qualcosa che le consente d’imporsi, talvolta attraverso potenti e maliziose strategie di convincimento, con l’arte cosmetica della persuasione, addirittura fin quando il “glorificato” non meriterebbe nemmeno quel processo di beatificazione mediatica sostenuto da operazioni commerciali più che dai meriti e dalle virtù. Senza voler in alcun modo avanzare nostalgici patetismi, emerge spontaneo il paragone tra le glorie del passato e quelle odierne. È ovvio che questo discorso, adesso come adesso, avrà vita breve, poiché il domani riserverà un nuovo oggi, che sarà comparato a questo, e via via lungo le coniugazioni temporali. Le glorie di ieri e quelle di oggi, dicevo. Già, perché quelle di ieri non soltanto ospitavano personaggi bravi col pallone, ma pure uomini che nella loro esistenza facevano da riserva alla vita, logorandosi in travagliate e commoventi storie personali, talvolta procurandosi del male, suscitando, insomma, la spontanea tenerezza degli appassionati e a volte pure di chi il calcio non lo seguiva.
I campioni del passato, un passato nemmeno così lontano, erano i titolari della prodezza e le precarie e scanzonate riserve delle quinte disordinate di vite ingestibili e furibonde. Chi in un modo, chi in un altro, ognuno di loro riusciva a lasciare il segno anche fuori dal campo, e paradossalmente pure con disastri e fallimenti, consegnando all’appassionato un campionario che gli sarebbe bastato per tutta una vita, onde parlare del suo idolo ai figli e ai nipoti. Disgrazie, tristi vicissitudini e feroci contraddizioni si assiepavano spesso nell’ombra dei campioni, un’ombra lunga e sottile, che faceva da coda interminabile al loro ricordo.
Oggi, invece, mi capita spesso di notare quanto l’immagine del fuoriclasse sia cambiata, e che la diffidenza che conservo nei suoi confronti sia determinata proprio da questo, che conti solo l’immagine, gran riserva da far circolare quando il campione si rivela l’uomo di paglia, il prestanome di invadenti sponsorizzazioni. Un esempio lo dà, ahimè, anche l’editoria, globalmente intesa. I giornali, le riviste, i libri, adottano in continuazione l’apologia del camerino, truccando volti e sagome come fossero copertine per il programma di un dèfilè. Il calciatore celebre è diventato una locandina di vanità. Non che in passato non lo fosse, ma la differenza stava nelle proporzioni, quando, oltre ai vizi, il calciatore serbava provanti vicende che all’indomani della sua ascesa lo avrebbero consegnato con una chiave così umana da riservargli l’assoluzione popolare anche per i suoi errori, perché quanto da lui vissuto non era soltanto manifestato dal volto talvolta arrogante del successo, ma pure da dure esperienze che lo umanizzavano al punto tale, da rendergli un’aura di disagio bisognosa di adozione.
Adesso, invece, molti calciatori, che valgono anche poco sul piano tecnico e agonistico, colorano la rassegna mediatica come se ognuno di loro fosse il manifesto sportivo da distribuire alle nuove generazioni. Sono gli alfieri della nuova volgarità, dati alla folla che ha ormai assunto un modo meccanico di acclamarli. Soggetti compositi, e non più complessi. Individualità da bricolage e non figlie di una gestazione morale e spirituale travagliata, esposta alla vita. Eccetto gli aneddoti che si portano dietro l’oggettiva commiserazione e quelli che presenziano il caos delle disavventure come ogni altra cosa al mondo, i calciatori di oggi commuovono poco. Sono la risultante di generazione nascoste, e non per grazia di discrezione e dignità, ma perché poco hanno da dire.
Spiaccicare un’immagine, uno scatto manipolato e corretto, di un fotografo moderno, lucidarlo come un totem virtuale, è passare la cera e lasciare un cartello con divieto di entrata. Così vicini, così lontani, verrebbe da pensare per questi “eroi moderni” che paiono più svezzati da un modista da rotocalco, piuttosto che dalla popolarità e dalle legittimazioni popolari. Privi di naturalezza, per nulla assediati dall’imbarazzo, dal sano e tenero disagio di fronte alla celebrità, si sono ormai abituati alle meccaniche di questa nevrotica comunicazione, e, più che mai smaliziati, hanno vestito i panni dei cacciatori d’attenzione. Hanno fatto sì che la popolarità si avvicinasse sempre più alla sua immagine più frivola e irritante, dando ragione a Jules Renard quando scrisse che “La gloria non è più che un genere coloniale”.
Anche quando aderiscono ad azioni rivolte alla sensibilità, lo fanno con ostentazione, con retorica e ipocrita riverenza a circolari intellettuali logore e mediocri. Per molti di loro provo antipatia, ma non di quell’antipatia che in qualche modo conserva rispetto e attenzione per chi potrebbe, con intelligenza e spirito contestatore, il moralismo dell’opinione comune – e ve ne fossero di questi antipatici -, ma un’antipatia che sa di inutilità, di ammissione che il cattivo gusto sia ormai necessario al costume popolare.
Così, sempre di più, il rettangolo di gioco diventa luogo di passaggio. E anche in campo, anche dove dovrebbe essere esercitata la difesa dell’onore, si riscontrano spesso atteggiamenti indolenti e insofferenti, spesso anche poco intuibili, perché da nulla determinati. Così, la gloria, onde evitare di mettere a rischio la sua reputazione, se ne sta buona e appagata sul capo di altri nomi.
Ora, il Lettore potrebbe giustamente contestare un eccessivo e retorico atto di accusa, uno sfogo unilaterale che non si sa bene da cosa provenga. Provo, quindi, ad aggiungere un ulteriore spunto di riflessione che, spero, meglio giustifichi quanto detto. E non si offenda la pazienza del Lettore se lo faccio nascondendolo dietro quanto una volta detto da Charles Baudelaire. “La gloria è il risultato dell’adattamento di uno spirito alla stupidità nazionale”.
sebastiano di paolo, alias elio goka
Last Updated on 8 Giu 2012 – 16:46 by
